È chiaro ad ogni persona di buon senso, almeno dalle discussioni che accompagnarono nel XVIII secolo la pubblicazione di Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, che il sistema carcerario di un Paese ne riflette il grado di civiltà. La nostra rivista Prisma si è occupata più volte della situazione delle carceri italiane, tra spazi non idonei, sovraffollamento critico, difficoltà di reinserimento e possibilità per i detenuti di accedere a percorsi di istruzione universitaria. Eppure… non se ne parla mai abbastanza. Così, dopo aver sfogliato le pagine della bella rivista trimestrale “SPAZIO diario aperto dalla prigione”, scritta tra le mura del carcere di Bergamo, abbiamo colto l’occasione di scambiare due parole con la responsabile, Adriana Lorenzi, insegnante di scuola secondaria di primo grado, per dar voce a chi il carcere lo conosce dal “di dentro” e fare il punto della situazione, soprattutto su un tema poco discusso come la presenza di detenute donne in realtà quasi esclusivamente maschili.
Numeri dal carcere
Attualmente nel carcere di Bergamo ci sono 592 detenuti su una capienza di 319. Mai così tanti negli ultimi 15 anni con un tasso di affollamento del 185,6%. A fine 2023 i reclusi erano 562, ma il 2024 è stato un anno “nero” per tutte le carceri d’Italia e anche quello di Bergamo ha registrato un aumento del 5,3% in poco più di un anno.
Per quanto riguarda in particolare la situazione femminile nelle carceri italiane, l’ultimo aggiornamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria segnala 2.729 donne recluse, su 62.165 detenuti, circa il 4% del totale. Bergamo segna un dato leggermente sopra la media con 40 posti per la sezione femminile sui 592 totali, quasi il 7%. Da questi dati appare evidente che i bisogni su cui sono tarate le carceri italiane sono valutati su dati maschili ed è un problema che non va sottovalutato.
Anche a livello di opportunità, il contesto del carcere maschile offre di più rispetto a quello femminile, infatti essendo la porzione femminile molto inferiore rispetto a quella maschile se si devono creare attività o stringere partnership con aziende si tendono a privilegiare i reparti maschili, anche solo per questioni puramente organizzative.
Spesso poi alle donne in carcere vengono affidati tutti i lavori di cura degli spazi, come la sistemazione degli uffici, la gestione della lavanderia di tutto il carcere, quindi i momenti in cui sono libere da impegni per dedicarsi ad altre attività sono pochi.
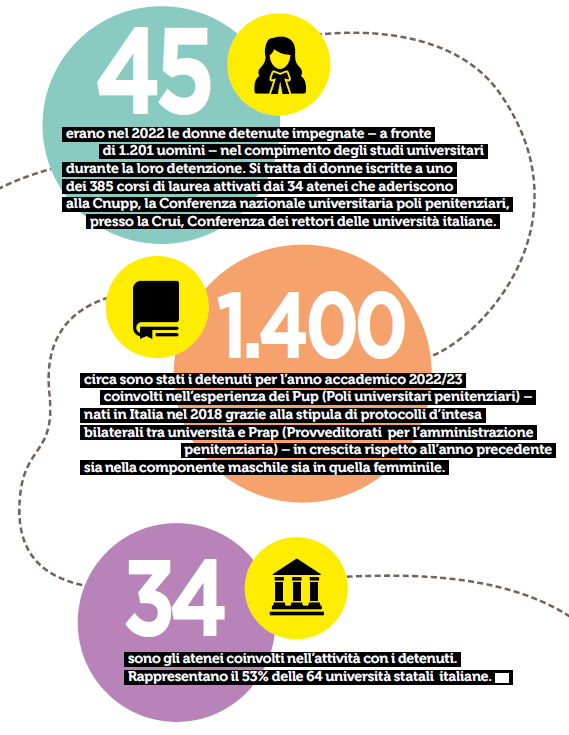
Pagina tratta dal numero 72 (marzo 2025) della rivista Prisma.
Il laboratorio del giornale “SPAZIO diario aperto dalla prigione” è un progetto trimestrale che, con il numero di dicembre 2024, ha festeggiato il traguardo dei dieci anni. Adriana Lorenzi, insegnante presso la scuola secondaria di primo grado di Urgnano, ha voluto con grande determinazione costruire questo progetto e con tenacia continua a portarlo avanti nonostante i vari ostacoli che a volte si presentano.
Adriana entra nella Casa Circondariale di Bergamo nel 2002 per condurre un laboratorio di scrittura autobiografica e memoriale nella sezione femminile, successivamente si sposta nella sezione maschile e negli anni, imparando a conoscere le storie dei detenuti e l’ambiente carcerario, intuisce che il laboratorio di scrittura possa essere uno strumento utile per un cambiamento e un arricchimento personale. Così nel 2014 nasce l’avventura editoriale “Spazio. Diario aperto dalla prigione”, insieme all’amica Paola Suardi che riesce a trovare i fondi per sostenere un giornale degno di tutto rispetto.
Il laboratorio di scrittura si è così trasformato in una vera e propria redazione in cui i detenuti sono diventati le “penne del giornale”. Scrivere frammenti delle proprie storie personali, familiari, professionali è l’occasione per rivisitare le scelte di trasgressione e violenza, per assumersi responsabilità e trovare la forza di costruire un proprio percorso di reinserimento sociale che tenga in considerazione i sentimenti delle vittime, della comunità e dei familiari. Nel laboratorio di scrittura, i racconti autobiografici si fanno testimonianze, forme di comunicazione che possono servire a ricostruire un contatto tra il dentro e il fuori. Chi scrive trova il coraggio di dire il reato commesso, scoprire la propria storia che può essere utile ad altri, trovando il modo di parlare a tutti.
“Mi piace pensare che la scrittura, alla quale invito le persone detenute, possa essere un gesto di riparazione, il rammendo di una vita ferita che ha ferito. Una forma di giustizia che non ha nulla a che vedere con l’amministrazione della giustizia. Una possibilità per riscrivere il proprio futuro.”
“Spazio. Diario aperto dalla prigione” rappresenta anche una sfida per tutti i cittadini nel cercare di dialogare con le persone detenute uscendo dagli stereotipi e dai pregiudizi comuni. Gli articoli rappresentano per i carcerati un’esposizione coraggiosa e sincera per darsi una nuova opportunità di vita e per i cittadini sono un’occasione di percepire che il proprio mondo di correttezza e onestà può essere stravolto improvvisamente dal turbine della violenza e del delitto per passione, avidità, rabbia, furbizia e desiderio. Per poter avere l’occasione di constatare la profondità dei testi, quanto la vita di ciascuno potrebbe essere improvvisamente stravolta e che giudicare non spetta a nessuno a questo link si trova il numero di dicembre 2024: https://drive.google.com/file/d/1L8jvKBhMl9oKnyCxRCYEpWqdo4IGIEr9/view?usp=drive_link
Ma lasciamo la parola direttamente ad Adriana:
In realtà come spesso accade nella vita alcune collaborazioni importanti nascono in maniera un po’ casuale.
Nel 2002 l’allora segretario della CISL di Bergamo mi chiese se volevo provare a interessare la sezione femminile del carcere della città, visto che risulta difficile coinvolgere la realtà femminile negli istituti di detenzione in attività aggregative, e la scrittura poteva essere un ottimo strumento. Io accettai la proposta sottolineando che il progetto avrebbe avuto senso solo se le persone avessero partecipato liberamente e non perché costrette. Così, per coincidenza proprio l’8 Marzo di quell’anno, andai a raccontare quello che facevo alle detenute presentando un libricino di racconti che avevo creato durante un lavoro in una casa di riposo. Ricordo che avevo letto dei brani e una detenuta di nome Lalla mi disse che le loro storie erano molto più interessanti perché avevano molto da dire, così le risposi che se lei aveva davvero voglia di esprimersi io sarei andata in carcere ogni settimana per aiutarle a scrivere la loro realtà. Lei non era fiduciosa, perché spesso le promesse non venivano mantenute, certo ci misi sette mesi per organizzare il progetto e superare la burocrazia, ma alla fine tenni fede alla parola data.
Cominciai con dieci incontri, poi venti e infine dal contesto femminile sono passata a quello maschile dove il numero di detenuti è molto maggiore e quindi potevo contare sulla continuità di presenza che permetteva al laboratorio di sopravvivere. Però ancora oggi grazie a Suor Margherita, che vive all’interno del carcere con le detenute e a cui faccio pervenire i temi che affronto nel laboratorio, se c’è qualcuna di loro che ha voglia di scrivere qualcosa in autonomia per il giornale consegna il testo alla suora che me lo consegna. La sezione femminile di Bergamo è gestita molto bene dalle suore, oltre a Suor Margherita ce ne sono anche due o tre che gestiscono la lavanderia insieme alle detenute.
Fin da subito il mio obiettivo è stato che le storie dei detenuti varcassero le mura del carcere in modo che la gente potesse vederli in maniera un po’ diversa, senza comunque togliere importanza al reato che è stato commesso e per il quale sono lì a scontare la loro pena. Però sono sempre persone che hanno una vita, sono genitori, figli o mariti che hanno bisogno di riparare la ferita che hanno fatto alla società e la scrittura li accompagna nel passaggio di assunzione delle proprie responsabilità.
Dal 2014 il laboratorio di scrittura è diventato ancora più strutturato ponendosi l’obiettivo di preparare del materiale da pubblicare in un vero e proprio giornale, quindi ci si trova il mercoledì di ogni settimana e si scrive prendendo spunto da temi e suggestioni che propongo cercando di avvicinare la realtà esterna e il carcere. Ci sono due regole fondamentali: la prima è che tutti devono scrivere e la seconda è che si legge ad alta voce il testo prodotto, per questo ho sempre richiesto ai vari direttori del carcere di non avere una guardia all’interno del laboratorio affinché potessero esprimersi al meglio.
Attualmente il laboratorio è frequentato da una decina di persone nella redazione del circondariale e una decina in quella del penale e chi frequenta la scuola all’interno del carcere per prendere la licenza media non può frequentare il laboratorio. L’alunno più anziano che ho avuto aveva 75 anni e il più giovane 20, mentre attualmente il più anziano ne ha 54.
Una cosa che apprezzano moltissimo è quando le persone esterne leggono il giornale e mi scrivono domande o commenti che io poi gli riporto perché per loro significa vedere il frutto del loro lavoro.
Nel corso di questi 20 anni ho imparato che le loro storie mi colpiscono e mi feriscono, poi però raccontandole a mio marito riesco a lasciarle andare e con esse anche l’angoscia. Andando una volta a settimana riesco a staccare e a ripartire ogni volta. Anche quando fanno le vittime io non li giustifico mai e rispondo che se sono lì un motivo c’è, però ciò che mi dispiace è vedere la condizione in cui vivono. Non vengono rispettati dei principi umani basilari come la pulizia e i metri quadrati e questo li rende delle vittime. Io credo nel fatto che il carcere fermi il male però deve anche cercare di far fiorire il bene.
A Milano, legato a San Vittore, c’è l’ICAM (Istituto a custodia attenuata per detenute madri, o padri nel caso in cui la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) dove stanno i bambini minori di tre anni con le madri. Lì l’organizzazione è più simile a una casa di accoglienza che ad un carcere, anche gli agenti, per esempio, non sono in divisa in modo che l’impatto sui bambini sia meno violento possibile. Ho lavorato per un po’ di tempo nella Casa di Reclusione Femminile “Giudecca” a Venezia che è una casa di reclusione non circondariale, quindi dove le pene sono più lunghe, e lì mi è capitato di vedere figli e madri vivere insieme in situazioni davvero difficili: i bambini si abituano a vivere la realtà carceraria e per questi la normalità è il carcere.
Secondo me un insegnamento importante del laboratorio è quello della collaborazione, infatti imparano ad esprimersi, a comunicare e a condividere il loro vissuto con gli altri, ma anche ad ascoltare e questo significa non concentrarsi esclusivamente su sé stessi e sulla propria storia. Un problema grosso di chi sta in carcere è di essere autocentrati, i propri problemi sono i più importanti e ciascuno vuole sempre avere ragione, ma quando iniziano a rispettare alcune regole e a collaborare il loro atteggiamento cambia diventando disponibili all’ascolto e ad accogliere anche le storie degli altri. Inoltre il laboratorio permette di rielaborare il proprio vissuto e di occupare il tempo con un’attività che loro sentono utile anche socialmente in quanto i testi servono per un giornale che uscirà da quelle mura arrivando alla comunità. Credo che questi elementi contribuiscano a farli crescere e cambiare, così come mi accorgo che imitando e imparando dagli altri evolve la loro scrittura.
Come dice la scrittrice inglese Jeanette Winterson esistono due diverse scritture: quella che scrivi tu e quella che scrive te. La prima pone l’accento sul prodotto per farsi capire dagli altri mentre la seconda sul processo che coinvolge sia il testo scritto sia il suo autore. Ed è in questa seconda fase che mi rendo conto di quanto cambiano e di quanto si aprono, anche se non chiedo mai le loro storie alla fine si rivelano. Spesso arrivano al laboratorio arrabbiati per situazioni vissute in carcere, ma, dopo averli ascoltati, li sollecito a lavorare anche su temi difficili su cui sono costretti a riflettere, in questo modo imparano che si affronta tutto.
Secondo me le difficoltà maggiori sono la coabitazione con persone che non hanno scelto e il fatto che non possano decidere assolutamente nulla in autonomia, ma dipendano totalmente da qualcun altro. Per esempio non hanno potere decisionale sull’orario di apertura delle celle, sull’orario della doccia o sull’ora per uscire all’aria e io sono testimone di tutta la loro fatica nel rispettare le imposizioni. Chi vive fuori dal carcere forse non si rende conto delle regole ferree che esistono, per esempio anche io all’interno del laboratorio devo sottostare ad alcuni obblighi che danno l’idea di come sia la vita lì: non si può abbracciare e nemmeno stringere la mano, non posso fermarmi nel corridoio a fare due chiacchiere se qualcuno che mi conosce mi chiede qualcosa. Si può entrare solo con zaini trasparenti, penne trasparenti, niente pennarelli, niente evidenziatori niente caramelle. Non si può entrare con la borraccia, ma con la bottiglia trasparente, niente USB, niente cuffiette, niente cappello, niente sciarpa. Le norme sono dettate da ciò che è successo, per cui magari le restrizioni possono cambiare anche da una settimana all’altra per motivi di sicurezza.
Un altro grosso problema è il sovraffollamento: infatti, trovarsi in celle previste per due persone in quattro, è per loro fonte di grande frustrazione e tensione. In estate il sovraffollamento è molto faticoso per il caldo mentre in inverno è causa di infezioni e diffusione virale. Forse qualcosa potrebbe essere migliorato per rendere la situazione meno pesante, perché anche se è vero che hanno sbagliato e che devono ricostruire il patto che hanno rotto con la società, la loro dignità non può e non deve mai venire meno.
A Bergamo ci sono ottimi servizi forniti dall’ UEPE e dall’Associazione carcere e territorio, che sono entrambe realtà di eccellenza, ma non riescono a soddisfare tutte le richieste. Funzionano molto bene quando c’è una pena alternativa o un affidamento per fare delle messe in prova, ovvero quando un detenuto giunge al termine di legge e può cominciare a lavorare all’esterno questi enti riescono a trovargli un lavoro spesso per i Comuni. Il periodo della messa in prova funziona in genere molto bene perché gli ex detenuti hanno voglia di uscire e di riscattarsi, però una volta finito trovare un posto di lavoro definitivo è davvero difficile. È uno dei rari casi in cui la parola “ex” è quasi impossibile da eliminare. Nessuno si presenta come ex moglie o ex figlia, invece ex detenuto è un’etichetta che è di difficile gestione quando si è alla ricerca di un lavoro e di una casa che sono i due elementi assolutamente necessari per la ricostruzione di una nuova vita. Spesso succede che a questo punto si scoraggino e non avendo magari nessuno che possa supportarli ed aiutarli è facile che ricadano nei meccanismi e nelle amicizie che avevano prima e questo li riporti nuovamente in carcere. Purtroppo anche all’interno del mio laboratorio ho visto situazioni di persone recidive e per loro tutto diventa più difficile, anche nei rapporti con i familiari: una volta si può essere perdonati, due diventa difficile.
PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).
Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.
L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.
Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).
3 risposte
Il tema del sovraffollamento delle carceri è un tema sempre più urgente, non è possibile avere questi dati nel 2025.
Complimenti ad Adriana Lorenzi per la sua preziosa collaborazione con le carceri e per la sua passione in questo progetto che riporta tutto ad una dimensione più umana.
Grazie Silvia Gambarini per aver affrontato e approfondito questo tema così importante ed attuale.
Devo ammettere di non aver mai posto particolare attenzione a come potessero vivere le donne detenute; è un tema che si tende ad ignorare non toccandoci da vicino .
Questo articolo ha evidenziato come ogni individuo pur avendo commesso degli errori merita di essere trattato con dignità e rispetto.
È fondamentale avere la capacità di guardare oltre le etichette e gli stereotipi comprendendo che dietro ad ogni persona c’è una storia e delle fragilità.
Fortunatamente esistono ancora persone altruistiche, che si dedicano ad offrire aiuto a chi si trova in difficoltà; credo che ciò, sia un’opportunità per tutti di noi di riflettere su come possiamo contribuire ad una società più umana .
In un mondo dove la critica è spesso più facile della comprensione, ritengo sia necessario, mantenere alto il senso di umanità e l’esempio di questa insegnate dimostra che ognuno di noi può fare la differenza.
Grazie Dott.ssa Gambarini .
Grazie per aver dato luce ad un mondo così vicino a noi ma così poco conosciuto e considerato.